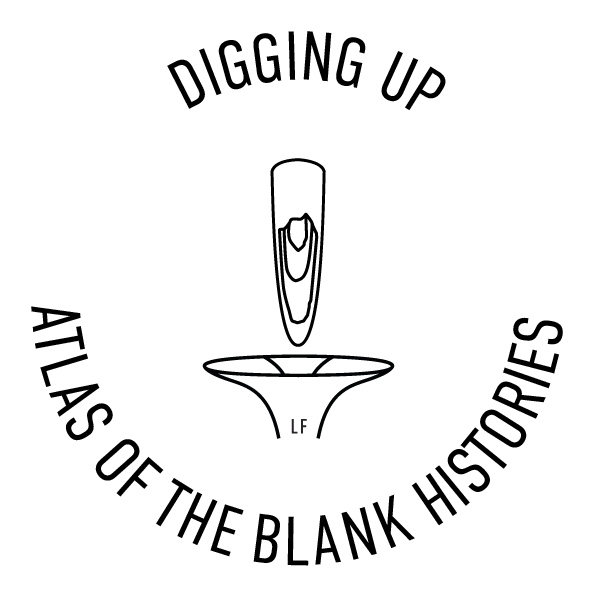L’austera facciata del cinquecentesco Palazzo Branciforte si impone nel reticolo di vicoli del centro storico di Palermo, nella successione dei suoi palazzi e chiese in tufo arenario. I fasti di una delle più potenti famiglie siciliane – in origine fu residenza progettata per i lussi cortigiani – si sono intrecciati qui con le sorti del popolo da esse governato: all’inizio del XIX secolo il palazzo divenne distaccamento del Monte dei Pegni di Palermo.
A metà del Settecento la famiglia Branciforte ottenne l’autorizzazione per un ampliamento del palazzo che inglobasse anche la strada antistante: alla struttura originale si aggiunsero così, fra i corpi di fabbrica, anche le scuderie coperte da volte a crociera, sostenute da colonne in marmo grigio del monte di Billemi. Successivamente il palazzo fu ceduto al Senato Cittadino per essere trasformato in una delle due sedi del Monte dei Pegni di Palermo. La nuova sede si distingueva da quella già esistente per la natura dei beni custoditi: se la principale, in via Api, era dedicata ai beni preziosi impegnati dalle classi sociali più facoltose, Palazzo Branciforte diventò il deposito dei pochi averi del popolo, già sofferente per l’aggravarsi delle finanze cittadine. Nel 1801, gli spazi della sede del Monte di Pietà di Palermo nel “piano della Pannaria” risultavano infatti insufficienti alle esigenze funzionali del “Monte della Pietà per la Pignorazione”. Così, il 23 novembre, il Governatore del Monte chiese di poter prendere a censo il Palazzo del Principe di Butera a Santa Cita per destinarlo, appunto, a seconda filiale del Monte, dove il 21 dicembre si insediò l’istituto. Tra il dicembre 1801 e l’aprile 1803 vennero completate le opere di ristrutturazione per adattare il palazzo a sede del Monte dei Pegni, chiamato “Monte Santa di Rosalia”, in onore della patrona della città.
La storia di Palazzo Branciforte si identifica da quel momento in poi con quella di un trauma, di una frattura storica collettiva: quella della povertà popolare al tramonto dei grandi regni. Le sale in cui un tempo Ercole Michele Branciforte – uno dei discendenti di don Placido Nicolò Branciforte e Lanza, Conte di Raccuja e Principe di Leonforte, che per primo si insediò nel Palazzo – organizzava i suoi ricevimenti in cui offriva agli ospiti sorbetti preparati con cinque tonnellate di neve trasportata dall’Etna, furono invase da un’onda stracci, vecchie lenzuola, cappelli, materassi, scarpe e indumenti malmessi. Il Monte di Santa Rosalia divenne una sorta di “pronto soccorso” economico della povera gente: tra il 1822 e il 1841 vennero eseguite circa 4 milioni di operazioni di pignoramento di biancheria, seteria e laneria. Il 17 gennaio del 1848, in occasione dei moti rivoluzionari, l’edificio fu colpito da una bomba incendiaria che provocò il crollo del tetto e delle volte sottostanti, causando gravi lesioni nella copertura della scuderia. Ricostruita la copertura dell’edificio, si decise di non ripristinare il solaio tra il primo e il secondo piano ma di realizzare una grande scaffalatura in legno in cui conservare, stipandoli su piani numerati, gli oggetti impegnati. Visibile ancora oggi, la struttura sale dal pavimento al soffitto e i suoi vari livelli sono collegati da un sistema di scale, ballatoi e palchetti intrecciati nella penombra degli ambienti. I commessi dei depositi erano conosciuti con il nomignolo di “uomini scimmia”: giovani di piccola statura con arti lunghi e agili, individuati per la loro capacità di arrampicarsi e spostarsi fra gli scaffali come fra i rami degli alberi.
È del 1929 la fusione fra il Monte di Pietà e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, istituto che continua per oltre cinquant’anni a mantenere l’attività di pignoramento degli oggetti non preziosi. Nell’aprile del 1943 i bombardamenti alleati della seconda guerra mondiale colpiscono il palazzo, distruggendo il loggiato superiore meridionale del cortile maggiore e parte dell’edificio e determinando così una nuova trasformazione nel corpo dell’edificio, oltre che la distruzione di ciò che era custodito nei depositi. Nel 1958 la Cassa di Risparmio ha incorporato la Fondazione Culturale “Lauro Chiazzese”, dal nome del suo Presidente prematuramente scomparso, e Palazzo Branciforte ne è diventata la sede. Lo stabile è oggi di proprietà di Sicilcassa, che ne ha affidato il restauro all’architetto Gae Aulenti. Al razionalismo architettonico fa da contrappunto l’indefinita, ambigua e oscura storia dell’assistenzialismo borbonico, che qui avveniva spalla a spalla con l’usura: le povere somme ricavate dal pegno servivano, molto spesso, solo a ripagare altri debiti, quelli contratti con gli strozzini che imperversavano appena fuori le mura del Monte di Santa Rosalia. Qui si è svolto il racconto della sopravvivenza attraverso la separazione dai propri beni, ma anche quello di quegli stessi beni che, cambiando di proprietà, subirono uno slittamento del loro significato intrinseco.
Gli oggetti del Monte di Santa Rosalia sono oggi scomparsi: restituiti, rubati, bruciati o dispersi. Il fruscio leggero della loro esistenza passata si avverte solo leggendo i libri mastri: registri che sono solo un simulacro del passato, in cui le minuziose annotazioni lasciate dai commessi restituiscono l’immagine astratta e spettrale del quotidiano scambio fra oggetti e identità.
Come i reperti “trovati” dai turisti a Pompei nel corso del XIX e del XX secolo, trafugati come souvenir e restituiti al sito tramite l’invio di una lettera, dopo che il rimorso del furto aveva assunto – in alcuni casi – le fattezze di una maledizione. La restituzione di porzioni di muri con tracce di affresco, di grossi chiodi probabilmente lasciati fra gli scavi dagli archeologi borbonici, di pietre, agglomerati di polveri, singole tessere musive staccate dalle pareti è un fenomeno di cui esiste infatti un’ampia casistica, ripresa negli anni dagli organi d’informazione, come in un articolo del “Daily Telegraph” del 14 ottobre 2015, che avvia la pratica di restituzione dei reperti a Pompei, e che è stato fra i materiali documentari su cui si è basata la ricerca preparatoria della mostra a Palermo.
I “pegni” restituiti negli ultimi decenni a Pompei, diversamente da quelli raccolti in passato dal Monte di Santa Rosalia, sono il regolamento di una transazione che esula dalle fluttuazioni del valore economico degli oggetti: al centro dello scambio non c’è, in questo caso, il valore storico e culturale di quei frammenti. C’è, piuttosto, il prezzo attribuitogli dalla coscienza individuale. L’atto di rispedirli nel luogo in cui si trovavano originariamente è il risultato di senso civico stimolato dalla superstizione o dalla percezione che il furto metta a rischio l’istinto di conservazione, di se stessi ma anche dell’identità di un luogo per come essa è definita attraverso una porzione della sua materia complessiva.
A partire dall’intreccio possibile di queste storie, che agiscono entrambe per sottrazione, si è definito il progetto della mostra DIGGING UP. ATLAS OF THE BLANK HISTORIES/Indagare il sottosuolo. Atlante delle storie omesse (16-24.06.2018) ospitata a Palazzo Branciforte, nell’ambito di Manifesta 12, quale prologo e in connessione alla presentazione del progetto a Villa Arianna (Castellamare di Stabia).
Gli ambienti di Palazzo Branciforte, intrisi di narrazioni e di accadimenti in cui la storia pubblica e quella alternativa dei singoli si intersecano, restituendo una tacita ma allusiva testimonianza degli eventi cittadini, divengono nuovi custodi dei reperti pompeiani restituiti negli ultimi decenni al sito archeologico, frammenti provenienti da un altro contesto, da un passato ancora più antico, carichi di suggestioni e storie, idealmente affidati anch’essi in pegno attraverso il loro temporaneo trasferimento al Monte di Pietà della Città di Palermo.
Questi oggetti resi sono corredati dalle lettere di restituzione indirizzate al Parco Archeologico di Pompei, testimonianze di storie laterali esposte insieme a una selezione di volumi storici relativi all’attività del Monte di Pietà palermitano, datati tra il 1560 e il 1950. L’identità stessa e le pratiche del Monte di Palermo, in particolare la trama di storie dismesse accumulate all’interno delle scaffalature del Monte dei Pegni di Santa Rosalia, la cui documentazione è andata perduta nell’incendio del 1848, emergono attraverso la fruizione di un ambiente orfano dei suoi pegni, ma i cui volumi documentano scrupolosamente l’attività e ne ricostruiscono la storia ufficiale. L’associazione tra questi tomi storici e la selezione di lettere e oggetti provenienti da Pompei è guidata dall’indagine dei passi estratti da ciascun testo, connesso ad altrettante testimonianze di accadimenti, sintomo di una temporalità annullata che si tenta attraverso il progetto di recuperare.
Tra i volumi esposti, vi è quello che raccoglie l’unico elenco degli introiti del Monte sopravvissuto all’incendio del 1848 (129. “Diversi moderni”, vol. VI, P. II, 1562-1672). Il tomo contiene una accurata descrizione della “roba” data in pegno, tramandando così le ekphrasis di oggetti per sempre assenti. A farvi da controparte è una costellazione di reperti trafugati e restituiti a Pompei i quali però, essendo stati estrapolati dal contesto originario, resteranno per sempre frammenti fuori posto. L’accostamento invece del “Libro generale di tutti li predi” (1723), che ribadisce l’istituzione del Monte per arginare la pratica dell’usura, garantendo ai poveri di vivere dignitosamente e la possibilità di riscatto, alle lettere che accompagnano la restituzione dei reperti a Pompei, scritte nella speranza di avere in cambio l’annullamento della sfortuna legata al possesso dell’oggetto, evoca l’idea di uno scambio su un piano immateriale.
Il vuoto lasciato dall’oggetto sottratto, che non potrà mai tornare al luogo di appartenenza, come quello del pegno che non verrà mai più restituito al proprietario o al luogo che ne era ormai depositario, costituiscono la storia primaria: l’avvio all’esplorazione di narrazioni alternative che funzionano da macchina del tempo, nel tentativo di ricostruire una piccola parte omessa della memoria storica di Palermo, esattamente come la Time Capsule che chiude il progetto pompeiano tenta di ricostruire quella della Pompei romana e contemporanea.