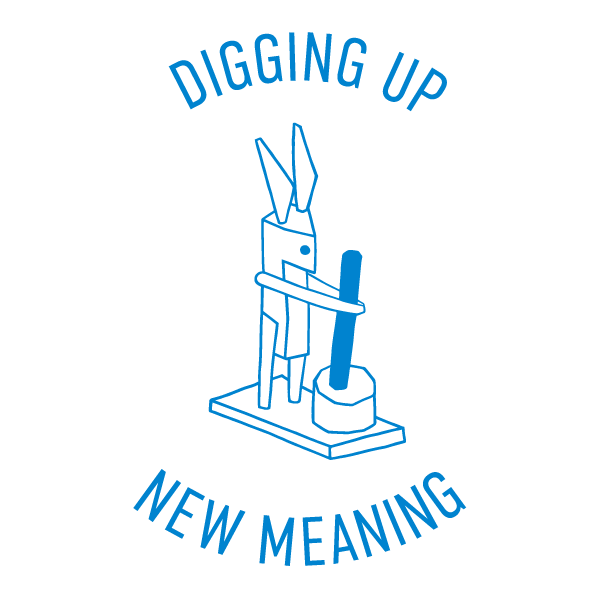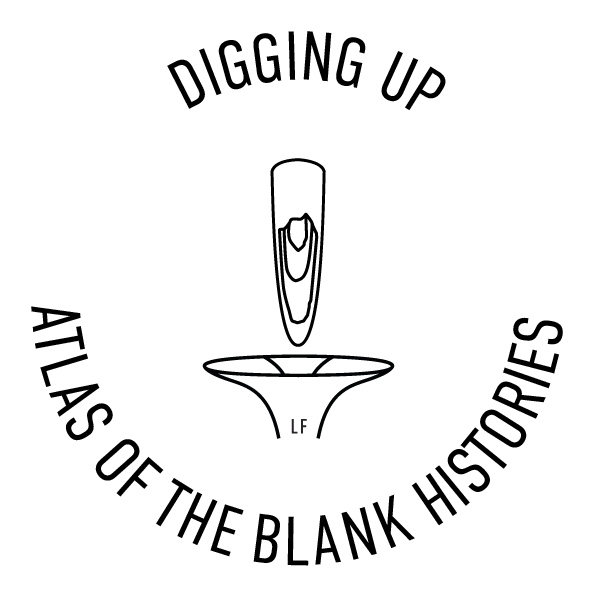Da questa artificiosa terra-carne. Andrea Zanzotto, Esistere psichicamente. È per eccellenza, en abîme, la scena-vertigine di Vertigo: la mano guantata di Kim Novak (Judy Barton [Madeleine]) percorre gli anelli che si susseguono sulla sezione della Grande Sequoia. “Manifesto” della natura non-sequenziale, non-lineare, vertiginante del tempo, che il film professa ed esplora (ben più esplicitamente dei precedenti, nella filiera Bruges-la-Morte → Nadja; nonché dei tanti più o meno postmodernisti spin-off a Vertigo ulteriormente seguiti). La successione degli eventi, dei piani-di-vita, si attorciglia a spirale (come il Riccio Rapito che, mercè il pigmalionismo di James Stewart [Scottie], definitivamente e micidialmente, plasma Judy in Madeleine; come le scale dell’oppressivo, mortifero campanile della missione di San Juan Batista; come gli astratti titoli di testa commissionati da Hitchcock a Saul Bass): «qui sono nata... e qui sono morta».

Scena estratta dal film La donna che visse due volte, Alfred Hitchcock, 1958.
Credo non risponda a una sincronicità junghiana, bensì a un preciso spirito del tempo, che le ricerche geocronologiche di Gerard De Geer si collochino fra il 1880 e il 1910 (il barone svedese le presentò al Congresso Internazionale di Geologia, a Stoccolma, nel 1910): contemporanee, dunque, a quelle che porteranno Freud alla descrizione della psiche come stratigrafia. Come altri suoi concetti-chiave, è questa un’idea dalla lunga e tortuosa evoluzione. Se in generale si può dire (lo ha fatto Paul Ricoeur) che «il tema dell’anteriore è la sua ossessione», questo tema si precisa – in relazione alla «topica» dell’inconscio, e diciamo allora (con James Hillman) alla sua «topografia» – lungo il contrastato decorso dell’attrazione-repulsione di Freud nei confronti della città per eccellenza stratigrafica che è Roma. E sarà infatti con un esempio riferito alla città eterna che l’immagine della psiche come stratigrafia si preciserà definitivamente (all’altezza del Disagio della civiltà, 1929): «Facciamo ora l’ipotesi fantastica che Roma non sia un abitato umano, ma un’entità psichica dal passato similmente lungo e ricco, un’entità, dunque, in cui nulla di ciò che un tempo ha acquistato esistenza è scomparso, in cui accanto alla più recente fase di sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti» (nel ’37 Freud paragonerà l’analisi, ormai esplicitamente, alla «ricostruzione che di un intero monumento antico propone un archeologo»).

Scena estratta dal film Viaggio in Italia, Roberto Rossellini, 1954.
Non bisogna pensare però che la ricchezza, che connota la stratificazione in questa immagine d’arrivo, sia un connotato rassicurante. Anzi. Commentando questi testi di Freud ha avvertito non a caso Tommaso Pincio (uno scrittore come me cittadino dell’Urbe, che come me ci è anche nato, ma che non ha mai nascosto nei suoi confronti un senso di inquieta estraneità – ben espresso da romanzi come Cinacittà, Panorama e il recentissimo Il dono di saper vivere – che a mia volta conosco sin troppo bene) che «Roma non è affatto immortale. È stata anzi (e in più di un frangente) una città morta, o che si credeva viva, e questo già prima che l’Impero cadesse». Il suo mito romantico e pre-, almeno da Piranesi in avanti, racconta un’interminata successione di morti sovrapposte (la «pasta di Martiri» di cui parlava Alessandro Verri, esploratore affascinato delle catacombe che scriveva dal proprio dorato esilio romano all’ancora-illuminista, ancora-milanese fratello Pietro): un palinsesto di sopraffazioni e violenze che prende le mosse dallo stesso atto di fondazione della Città – il sacrificio rituale di Remo da parte del fratello Romolo. Lo ha mostrato da ultimo William Kentridge (che evoca, in coda a questa scia di sangue, il cadavere di Pasolini riverso bocconi all’Idroscalo di Ostia), nel fregio-sfregio col quale di recente ha voluto rendere il suo ambiguo omaggio a Roma. È una città, questa maledetta mia città, che si fonda dunque su un omicidio – e anzi, più precisamente, su un fratricidio (etimo che da Roma si riverbera sull’identità italiana nel suo complesso: impossibile la rivoluzione – diceva Umberto Saba in un passo famoso delle sue Scorciatoie e raccontini – in un paese dove non si ammazzano i padri, bensì i fratelli).
Sempre Pincio ricorda l’insofferenza dichiarata, per Roma, da Dostoevskij (nel corso di un viaggio fatto nel 1863). A differenza del venerato maestro Gogol’, che una ventina d’anni prima vi aveva soggiornato a più riprese e con piena soddisfazione, da Roma Dostoevskij viene abbattuto e stremato, specie per le distanze interminabili da percorrere a piedi: «la meraviglia di Roma è opprimente, eccessiva, persino disumana. Roma è un luogo sproporzionato. Il suo monumento più rappresentativo, il Colosseo, pare concepito al solo scopo di rendere minuscoli e irrisori gli uomini […]. A Roma, le distanze erano e restano spropositate, insensate», commenta Pincio. Già quarant’anni prima, proprio di questo si lamentava Giacomo Leopardi quando, dopo averla tanto vagheggiata, effettivamente s’era trovato a soggiornare in «questa città che non finisce mai», fra il novembre del 1822 e l’aprile dell’anno seguente («tutta la grandezza di Roma non serve ad altro che a moltiplicare le distanze […]. Queste fabbriche immense, e queste strade per conseguenza interminabili, sono tanti spazi gittati fra gli uomini, in vece d’essere spazi che contengano uomini»).
Ma ad atterrire maggiormente non è tanto l’estensione in latitudine, della città (e delle sue sterminate, oggi sempre più disumane, periferie); bensì quella in verticale. La città palinsesto – in cui accanto alla più recente fase di sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti –, di cui parlerà alla fine un Freud rasserenato, in precedenza aveva rappresentato per lui, invece, un autentico incubo. Sarà il caso, anzi, di parlare più propriamente di un complesso: che del resto, con la consueta attitudine autoanalitica, lo stesso Freud confessa in una pagina dell’Interpretazione dei sogni (nonché, in privato, nelle lettere a Wilhelm Fliess dello stesso periodo). Prima di soggiornarvi ben sette volte, fra il 1901 e il 1923, a più riprese Freud aveva tentato di approdare a Roma, finendo però ogni volta per ritrarsene all’ultimo momento (come era capitato – racconta appunto nel libro sui sogni – a quello che, nell’infanzia, era stato il suo eroe proiettivo: il nemico di Roma per eccellenza Annibale). Più che dovuta all’Edipo passepartout (Roma alma mater della civiltà occidentale nei confronti della quale teme di commettere incesto, come ritiene Musatti), o all’avversione insanabile dell’ebreo Freud nei confronti della città simbolo del cristianesimo (come ritiene Timpanaro), è possibile che a essere messo in scena in quella forma fobica fosse invece il travaglio della scoperta e del conseguimento di quell’archeologia del profondo i cui protocolli si annunciavano proprio nell’opera entro la quale tale complesso veniva confessato (ma anche, in tal modo, “elaborato”: infatti il sospirato approdo alla città-palinsesto si renderà possibile, per lui, giusto all’indomani della pubblicazione dell’opera), e che alla fine verranno da lui riconosciuti nel loro etimo geografico.
Non è un caso che l’autore più intensamente “psichico” del nostro Novecento letterario, Andrea Zanzotto, nutrisse una simile ambivalenza nei confronti del «buio» che si trova «sotto i piedi dell’uomo», come lo chiama in una straordinaria pagina critica del 1953, L’inno nel fango: l’«abisso temporale» che dalla storia umana, calcolata in millenni, si dilata in quella geologica, che si misura in «miliardi di anni». Zanzotto era ossessionato da «residui» – «veri signori del mondo», li definisce – che sono anche quelli di una storia traumatica e mai davvero elaborata, quella tragica della guerra senza fine del Novecento che aveva insistito con massima efferatezza nel locus in apparenza amœnus della sua Heimat veneta. Lui stesso si raffigura in un’incredibile poesia degli anni Cinquanta, Fuisse, come un reperto fossile che ci parla dalle viscere della terra, un Io-Reperto sepolto in un passato immemorabile e da lì «versato nel duemila». Ambivalenza insolubile è quella per cui la terra è sepoltura profanata senza culti, «arcadia horror» dalla quale emergono, atroci e inarticolati, «pezzi di guerra sporgenti da terra»; ma anche – nel medesimo libro che alle stragi del Secolo Breve è dedicato, Il Galateo in Bosco – la matrice della materia biologica colla quale i suoi genitori lo «combinarono, sotto quelle caterve di os-ossa».
Dall’aulico-classicista Seamus Heaney di Scavare, che risale ai suoi esordi anni Sessanta, al Valerio Magrelli di Geologia di un padre e al Tommaso Ottonieri di Geòdi, che sono invece dei nostri anni, tanti sono gli autori ad aver indagato come questa topica “archeologica” – che, almeno dal romanticismo di Chateaubriand e Senancour in poi, tante volte s’è affacciata nella tradizione letteraria – comporti un cortocircuito tra l’architettura della nostra mente, più o meno freudianamente intesa, e la struttura del tempo. Colui che tale cortocircuito ha esposto più compiutamente è stato forse Carlo Emilio Gadda in una poco nota quanto vertiginosa, è il caso di dire, pagina del 1934. In Un romanzo giallo nella geologia (reportage dalla Marsica cinque anni dopo raccolto nelle sue Meraviglie d’Italia) si trova l’intuizione che «la catena delle cause remote, cioè l’acquisita cognizione del profondo» (secondo quello che di Gadda è un principio gnoseologico complessivo, più avanti enunciato nell’Opinione sul neorealismo dei Viaggi la morte), vada rinvenuta appunto archeologicamente: nella dialettica fra superficie e sotterranei, fra estensione e profondità, fra presente e passato. C’è già tutto – come indica il titolo dato al reportage – il palinsesto del giallo “metafisico” che di Gadda sarà il capolavoro nonché l’opera estrema e consuntiva che metterà fine alla sua attività, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (uscito, dopo travagliatissima elaborazione, giusto lo stesso anno di Vocativo di Zanzotto): dove alla Roma del suo tempo, anni Quaranta e Cinquanta, è sottesa quella fascista degli anni Venti, e sotto ancora occhieggia, con remotissima luccicanza onomastica, quella classica dell’archetipico epos virgiliano (classica sì, ma “freudianamente” perturbante; e si ricorderà come Freud avesse posto un esergo virgiliano proprio all’Interpretazione dei sogni), poi sempre più giù sino a giungere, per dirla colle sue parole, al «suggerimento cristallografico di Dio».
Esponendo sulla pagina, come nella teca di un museo di scienze naturali o appunto di geologia, reperti fossili più o meno umani (al di là della sua origine un corpo umano fossilizzato a sua volta diventa, si capisce, un reperto geologico), questi autori suggeriscono che il tempo, così come appunto la materia, non si possa leggere secondo un ordinamento sequenziale, lineare. Perché in effetti tanto in geologia che in psicoanalisi, come si è visto, il modello più attendibile è bensì quello stratigrafico: fatto di una linea sì, ma che non procede in linea retta bensì curva, sino a piegarsi e schiacciarsi su se stessa; sino – al limite – a combaciare, sovrapporsi e introdursi su se stessa. È il modello “geologico” che nel pensiero del nostro tempo ha introdotto Gilles Deleuze quando ha parlato – a proposito dell’episteme “barocca”, tanto cara a Gadda quanto a Zanzotto – di una morfologia della piega: dove s’invoca «una “crittografia” […] capace di penetrare nei ripiegamenti della materia e di leggere al contempo nelle pieghe dell’anima». Così si scopre che «la materia-piega è una materia-tempo»; ed è in questo modo, infatti, che si rende concepibile un “viaggio nel tempo” che, se in termini fisico-tangibili resta einsteinianamente impossibile, in termini psichici (e dunque, nell’accezione deleuziana di immanenza, comunque materiali) è invece qualcosa di cui facciamo continuamente esperienza. Questo appunto è il vero tema di Vertigo, della Jetée di Chris Marker (che a Vertigo del resto s’ispira) e dell’Esercito delle dodici scimmie di Terry Gilliam (che invece riprende proprio La Jetée).

Scena estratta dal film Viaggio in Italia, Roberto Rossellini, 1954.
Ma prima di tutti questi film ce n’è un altro che, almeno in apparenza, nulla ha di fantascientifico né di misterioso. E che meglio di ogni altro, però, ha interpretato la dimensione che sino a questo punto ho cercato di tratteggiare: finendo col trovarne l’ambientazione ideale proprio nell’hinterland di Napoli. Non a caso, dunque, in quella che Walter Benjamin chiamava «la città porosa», indicandone l’etimo manifesto negli scavi di Pompei («tutto ciò che il forestiero desidera, ammira e paga è “Pompei”»). La tormentosa partita di scherma fra gli algidi e nevrotici coniugi britannici Katherina e Alex Joyce (Ingrid Bergman – già musa hitchcockiana, a sua volta sempre inquadrata colle delicate mani ben protette dai guanti – e George Sanders) nel Viaggio in Italia di Rossellini, postrema reincarnazione dei viaggiatori del Grand Tour d’antan, si svolge infatti per intero nel recinto magico che racchiude le Solfatare di Pozzuoli, il Cimitero delle Fontanelle alla Sanità – e appunto Pompei. Una volta quello che è il più grande pensatore dell’arte di oggi, Georges Didi-Huberman, ricordando proprio quella vecchia pagina di Benjamin, ha esemplificato la sua concezione anacronistica, della storia non solo delle immagini (concezione dalla dichiarata matrice appunto benjaminiana, oltre che warburghiana), proprio in questi luoghi napoletani nei quali si riscontra la medesima stratificazione che Freud divinava in Roma: «come in ogni città che ha vissuto molti tempi, qui questi si sovrappongono, irrompono l’uno nell’altro anche fisicamente». Indicando le capuzzelle, la miriade di teschi alle Fontanelle schierati a strati sovrapposti come eserciti di terracotta uno accatastato sull’altro: «si vede in quest’architettura a tagli di luce violenti, quasi piranesiani, che convive con l’informe terriccio di morte, col tappeto di ossa alla sua base». È in luoghi come questi che si assiste all’«insorgere dell’eterogeneo: di diverse temporalità che s’intrecciano, s’incrostano una nell’altra». Qui «viene alla luce questa temporalità impura, plurale, intrinseca all’arte. Le forme dell’arte rinviano sempre a un fondo ulteriore, qualcosa di segretamente radiante che sta sotto e continua a pulsare».

Scena estratta dal film Viaggio in Italia, Roberto Rossellini, 1954.
È proprio questa pulsazione vitale e disturbante, trasmessa dalle spoglie mortali che, in forma di calchi in gesso, letteralmente emergono dalla terra a Pompei, a gettare nell’angoscia Ingrid Bergman (Katharine Joyce) nel film di Rossellini. In un uomo e in una donna sorpresi dalla furia della terra duemila anni prima, e dall’archivio della terra avvinti l’uno all’altra per l’eternità, ma all’improvviso messi a nudo dallo sguardo indiscreto dell’archeologo, lei rivede come in sogno il proprio stesso destino di coppia: una morte in vita intollerabile ma da anni, in effetti, tollerata in silenzio. Solo allora, commenta Martin Scorsese, «finalmente i loro occhi si aprono». Lei, sempre turbata, esclama «la vita è così breve»; al che lui, deciso, ribatte: «per questo dovremmo godercela». Alla fine di Fuisse l’Io-Fossile di Zanzotto, «riversato dal nulla» negli «strati della terra» che «nel silenzio ricadono», seppur con un punto interrogativo in clausola, ci dice che «versato nel duemila» è «anche per noi» che le sue «labbra», malgrado tutto, «dall’assenza / debolmente si muovono».
È proprio vero che il futuro ha un cuore antico.

Scena estratta dal film Viaggio in Italia, Roberto Rossellini, 1954.
Nota
Vertigo, regia di Alfred Hitchcock, 1958 (in Italia La donna che visse due volte, dal romanzo del 1954 di Thomas Narcejac e Pierre Boileau, D’entre les morts, da ultimo edito come La donna che visse due volte da Adelphi, nella traduzione di Federica Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco, nel 2016; si veda Victor I. Stoichita, Effetto Pigmalione. Breve storia dei simulacri da Ovidio a Hitchcock, traduzione di Benedetta Sforza a cura di Aurelio Pino, il Saggiatore 2006; le parole di Madeleine nel Parco delle Sequoie: https://www.youtube.com/watch?v=IJpo-z2m3dI). Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte [1892], da ultimo nella traduzione di Paola Decina Lombardi, Bruges la morta, Mondadori 1997 (si veda Emanuele Trevi, Il demone della somiglianza, postfazione all’edizione tradotta collo stesso titolo da Catherine McGilvrey, Fazi 1996 – non ripresa nella recente ristampa ivi 2016); André Breton, Nadja [1928]; della traduzione di Giordano Falzoni esiste una riedizione con prefazione di Domenico Scarpa, Einaudi 2007, ma resta preferibile la prima edizione italiana, con una nota di Lino Gabellone, ivi 1972 (rinvio al mio Bruges-la-Morte, Nadja, Vertigo. Psicologia di tre città, in Dal Nulla al Sogno. Dada e surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans Van Beuningen, catalogo della mostra di Alba, Fondazione Ferrero, 27 ottobre-25 febbraio 2019, a cura di Marco Vallora, Silvana 2018, pp. 334-43).
Di Sigmund Freud sono citati Il disagio della civiltà [1929], in Id., Opere, edizione diretta da Cesare Musatti, vol. X, Boringhieri 1978 (a p. 563), Costruzioni nell’analisi [1937], in Id., Opere, cit., vol. XI, ivi 1979 (a p. 545) e L’interpretazione dei sogni [1899], in Id., Opere, ed. cit., vol. III, ivi 1966 (alle pp. 185 sgg.; l’esergo ricordato oltre è «Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo», dal VII dell’Eneide, ossia «la parte nascosta, invisibile della realtà non è meno importante di quella visibile»: Carlo Ginzburg, Spie [1979], in Id., Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Einaudi 1986, p. 197n); cfr. Paul Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud [1965], traduzione di Emilio Renzi, il melangolo 1991, p. 405; e James Hillman, Il sogno e il mondo infero [1979], traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2003, pp. 28 sgg. (e cfr. pp. 233 sgg.). Lo riprendono Tommaso Pincio nel capitolo «Criptoamnesie», alle pp. 61-77 del suo Pulp Roma, il Saggiatore 2012 (qui anche il commento su Dostoevskij, alle pp. 16-7; si riferisce alla lettera del settembre 1863 che si legge in Fëdor M. Dostoevskij, I demoni quotidiani. Lettere, a cura di Ettore Lo Gatto, vol. I, 1837-1867, Aragno 2017, pp. 299 sgg.) e Vittorio Lingiardi in Mindscapes. Psiche nel paesaggio, Cortina 2017, pp. 125-7 e 137-42 (ma il commento più accanito, un vero implacabile corpo a corpo, è quello di Sebastiano Timpanaro in La «fobìa romana» di Freud, un articolo del 1985 divenuto un volumetto nel 1992 e ulteriormente ampliato in Id., «La fobìa romana» e altri scritti su Freud e Meringer, a cura di Alessandro Pagnini, ETS 2006, pp. 53-110; cfr. Cesare Musatti, Freud e l’ebraismo, in «Belfagor», XXXV, 1980, pp. 687-96; poi in Id., Ebraismo e psicoanalisi. Il pensiero politico e sociale di Freud, Studio Tesi 1994).
La «pasta di Martiri» viene trovata da Alessandro Verri nelle sue esplorazioni nelle catacombe romane, e descritta in una lettera al fratello Pietro del gennaio 1793 («Io trovai nelle catacombe di S. Lorenzo delle ossa molte, ed esse sono ridotte dal tempo ad essere come una pasta pura, che chiamano pasta di Martiri, e trovai anche qualche buca di deposito non aperta, che aprii e vi trovai gli scheletri al solito»: rinvio al mio L’antiquario fanatico e l’ombra di Vitruvio. Sincretismo estetico delle Notti Romane di Alessandro Verri, in Italia e Italie. Immagini tra Rivoluzione e Restaurazione, atti del convegno di Roma, 7-9 novembre 1996, a cura di Mariasilvia Tatti, Bulzoni 1999, pp. 346-7). Triumphs and laments è il titolo del murale di oltre cinquecento metri di lunghezza realizzato da William Kentridge, nella primavera del 2016, fra Ponte Sisto e Ponte Mazzini (rinvio al mio William Kentridge, il tempo che scorre, in «alfabeta2», 14 maggio 2016, alle pp. 291-3 di Almanacco 2017. L’invasione aliena, a cura di Nanni Balestrini, Maria Teresa Carbone e mia, DeriveApprodi 2016). Di Umberto Saba è citata la «scorciatoia» numero 4, che si conclude così: «Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli» (Scorciatoie e raccontini [1946], in Id., Tutte le prose, a cura di Arrigo Stara, introduzione di Mario Lavagetto, Mondadori 2001, p. 8). Di Giacomo Leopardi sono citate le lettere al padre Monaldo del 22 dicembre 1831 e alla sorella Paolina del 3 dicembre 1822 (a p. 80 e a p. 10 di Id., Questa città che non finisce mai. Lettere da Roma 1822-32, postfazione di Emanuele Trevi, Utet 2014).
Di Andrea Zanzotto il saggio (su Montale) L’inno del fango, del 1953, in Id., Fantasie di avvicinamento [1991], in Id., Scritti sulla letteratura, a cura di Gian Mario Villalta, Mondadori 2001, vol. I, p. 18; e le poesie Fuisse in Id., Vocativo [1957], e Rivolgersi agli ossari in Id., Il Galateo in Bosco [1978], in Id., Le Poesie e Prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario Villalta, saggi introduttivi di Stefano Agosti e Fernando Bandini, Mondadori 1999, pp. 186 sgg. e 565-6 (ma la topica geologica si estende sino all’opera ultima Conglomerati, Mondadori 2009), e l’intervista La poesia e il sublime, risultante da colloqui che ebbi con lui fra il 2002 e il 2005, in «Galatea. European magazine», novembre 2005, pp. 30-7. Non meno psichici il Tommaso Ottonieri delle Strade che portano al Fùcino, Le Lettere 2008, e di Geòdi, Aragno 2015; e il Valerio Magrelli di Geologia di un padre, Einaudi 2013 (prosa in cui precipita una topica di lunga durata, sulla quale rinvio a Valerio Magrelli, l’occhio, la terra, la salute, nel mio La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti italiani 1940-2005, Fazi 2006, pp. 410-37 e 733-43). Scavare (Digging) s’intitola la poesia iniziale della prima raccolta di Seamus Heaney, Morte di un naturalista, pubblicata nel 1966 (ora in Id., Poesie scelte e raccolte dall’autore, a cura di Marco Sonzogni, Mondadori 2016, pp. 6-9); con L’uomo di Grauballe (poemetto contenuto nella raccolta North, del 1975, ivi, pp. 142-5) Heaney fonda anche una tradizione di singolare (ma non casuale) fortuna italiana, quella che di reperti umani rinvenuti in giacimenti più o meno preistorici fa un’allegoria della persistenza della memoria filogenetica sottesa al decorso cronologico della storiografia vera e propria: lo riprendono Fabio Pusterla in Bocksten, Marcos y Marcos 1989 (alle pp. 25-79) e Franco Buffoni in Tecniche di indagine criminale, in Id., Il profilo del Rosa [2000], in Id., Poesie 1975-2012, a cura di Massimo Gezzi, Mondadori 2012 (a p. 120) e in Nel più alto campo di battaglia, in Id., Guerra [2005], ivi (a p. 221). Su tutto questo rinvio al capitolo «Post-Factum. La guerra postuma» nel mio Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale [1998], Bompiani 20182 (alle pp. 619-66; e cfr. Matteo Giancotti, Paesaggi del trauma, Bompiani 2017).
Di Gadda sono citati Un romanzo giallo nella geologia [1934], in Id., Le meraviglie d’Italia [1939], a cura di Liliana Orlando in Id., Opere, edizione diretta da Dante Isella, Saggi giornali favole-I, Garzanti 1991, pp. 145-51; Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [1957], a cura di Giorgio Pinotti, Adelphi 2018, p. 255; Un’opinione sul neorealismo [1951], in Id., I viaggi la morte [1958], in Id., Saggi giornali favole-I, cit., pp. 629-30: «Un lettore di Kant non può credere in una realtà obbiettiva, isolata, sospesa nel vuoto; ma della realtà, o piuttosto del fenomeno, ha il senso come di una parvenza caleidoscopica dietro cui si nasconda un “quid” più vero, più sottilmente operante, come dietro il quadrante dell’orologio si nasconde il suo segreto macchinismo» (su questo si veda Giancarlo Alfano, Percorsi orizzontali e vettori verticali. Lo spazio nel Pasticciaccio, in Id., Paesaggi mappe tracciati. Cinque studi su letteratura e geografia, Liguori 2010, pp. 71-90). La Jetée, regia di Chris Marker, 1962 (su Vertigo Marker ha scritto pagine di grande interesse in A free replay. Notes sur «Vertigo», in Le cinéma vu par les cinéastes, numero monografico di «Positif», 400, giugno 1994, pp. 79-84); 12 Monkeys, regia di Terry Gilliam, 1995. Di Gilles Deleuze è citato La piega. Leibniz e il Barocco [1988], a cura di Davide Tarizzo, Einaudi 2004 (le citazioni a p. 6 e a p. 11).
La celebre definizione di Napoli «città porosa» è nella prosa scritta da Walter Benjamin a quattro mani con Asja Lacis, Napoli, pubblicata nel 1925 sulla «Frankfurter Zeitung» (in traduzione italiana, nel 1979, sul numero 9-10 della rivista «Es»; si legge ora, nella traduzione di Helmut Riediger, in Id., Opere complete, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, edizione italiana a cura di Enrico Ganni, vol. II, Scritti 1923-1927, Einaudi 2001, pp. 37-46, la citazione a p. 38). Viaggio in Italia, regia di Roberto Rossellini, 1954 (qui, https://www.youtube.com/watch?v=9DW-Zb-HESo, la scena di Pompei col commento in voice off di Martin Scorsese, tratta dal suo documentario di montaggio che prende il titolo proprio dal film di Rossellini, Il mio viaggio in Italia del 1999; su Youtube è altresì disponibile la versione integrale di Viaggio in Italia restaurata nel 2012: https://www.youtube.com/watch?v=CJ9e0ReGwy8). Di Georges Didi-Huberman è citata l’intervista che gli feci nel 2008, appunto al Cimitero delle Fontanelle, in occasione del Premio Napoli da lui vinto col saggio Ex voto (pubblicato quell’anno da Cortina): Necropoli in fiamme, in «Il Caffè illustrato», VIII, 46-47, gennaio-aprile 2009, pp. 87-8 (si vedano i suoi magnifici Storia dell’arte e anacronismo delle immagini [2000], traduzione di Stefano Chiodi, Bollati Boringhieri 2007, e L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte [2002], traduzione di Alessandro Serra, ivi 2006).