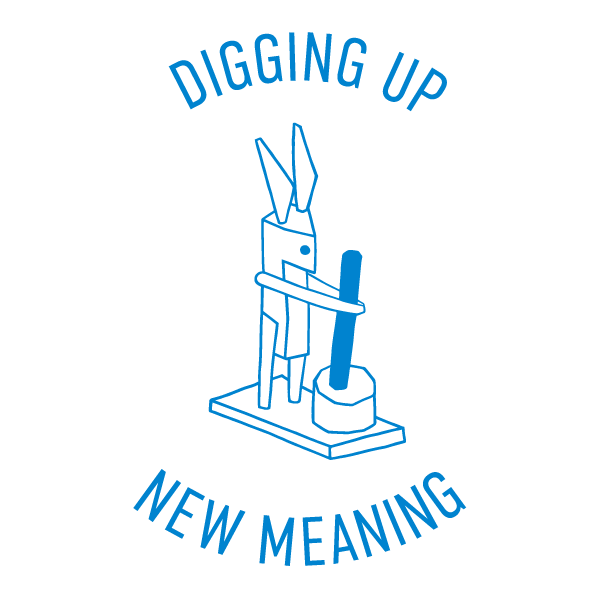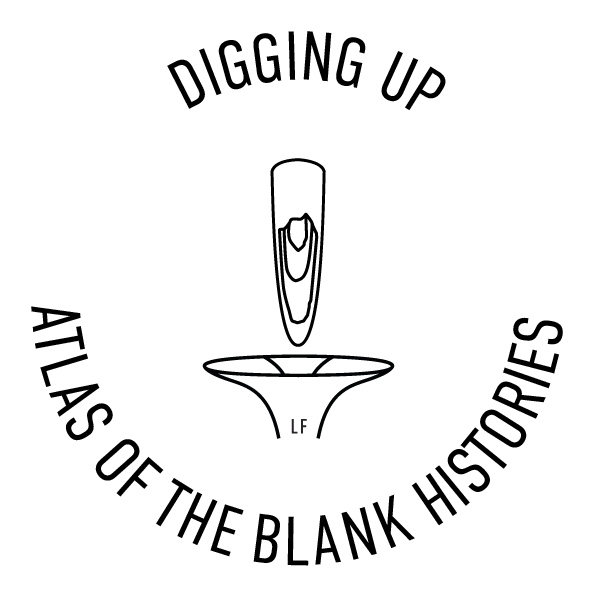Lo aveva detto mia madre, io avevo capito Farina, avevo pensato che parlasse dell’intonaco che poco a poco, una notte dopo l’altra, facevo nevicare giù dalla parete e che poi cercavo di eliminare soffiandolo via – ma eliminarlo così non andava bene perché mi ero accorto che al mattino quella cenere bianca sulle lenzuola si notava – oppure sparpagliandolo sul pavimento – sempre entro dei limiti, la casa era pulitissima e quindi anche solo qualche corpuscolo di polvere sarebbe stato subito percepito – o mescolandolo alla saliva per farne una pallina che poi nascondevo nella tasca dei pantaloni e il giorno dopo gettavo via per strada andando a scuola. Invece – era diventato chiaro quando lo aveva ripetuto – aveva detto Faria. L’abate Faria, aveva detto. O meglio: Pensi di essere l’abate Faria?, e dicendolo si era sporta oltre il mio letto a guardare da vicino il frammento di carta da parati lacerato e qualche centimetro di parete scorticato. Dovresti lasciarlo in pace, il muro, aveva detto e poi aveva ripetuto Abate Faria, L’abatino, Il mio abatino, e mi aveva toccato la testa – avevo i capelli cortissimi, avevo sentito il palmo caldo che seguendone la curvatura aderiva alle ossa del cranio – e poi, ancora, sulla soglia della mia camera, girandosi verso di me ma già parlando a se stessa, Vuoi fare come nello sceneggiato?, aveva detto, Passare anni e anni a scavare per evadere?, e un attimo dopo, imboccato già il corridoio, E poi dove pensi di andare? Viviamo al terzo piano e quello che stai scavando è un muro perimetrale, dall’altra parte c’è il pozzo luce, vuoi scavare fino alla fine del muro e poi cadere giù?, oppure ti importa solo scavare?, e a quel punto, sul verbo all’infinito, la voce si era dissolta, persistendo però in forma di eco dentro la mia testa – scavare scavare scavare – e precisando esattamente quello che desideravo: scavare, solo scavare, poco a poco lacerare con la punta delle dita la carta da parati di un tessuto sintetico puntinato a quadrettini azzurri bianchi e celesti, modellando i frastagli per formare figure diverse – la casetta, il fiore, le foglioline, la testa del gatto con le orecchie a punta, ma anche i corpi intuiti e desiderati e temuti: i mostri genitali –, ma soprattutto volevo continuare a superare quella doppia pelle, la carta da parati e l’intonaco, esaurire una superficie e passare alla successiva, perché dietro una pelle ce n’era sempre un’altra, la superficie non finiva mai, io scavavo e la superficie all’apparenza svaniva, in realtà solo si contraeva, si rimarginava, riaffiorava, scaturiva di nuovo fuori da se stessa, una condizione che mi avviliva ed era bellissima, perché a me l’indomabilità della superficie piaceva, mi piaceva che il mio compito notturno non avesse fine, e così, dopo che mia madre si era accorta della lacerazione e della scalfittura, avevo continuato, ogni sera, prima di dormire, a rosicchiare con l’unghia la materia, disteso a letto, al buio, per cinque minuti, a volte di più, non sapevo mai bene quanto tempo passasse perché mi addormentavo scavando, con le falangi indolenzite, il polpastrello spellato, il cunicolo accanto a me che poco a poco si inoltrava in direzione di quello che mia madre chiamava il pozzo luce, e che però per me era un’altra cosa, una cosa che mescolava il buio, la luce nel pozzo dall’altra parte, il vuoto, la materia piena che non finiva mai. Era la primavera dei miei nove anni e quando arrivava la sera io diventavo Faria. Dopo qualche giorno mia madre era tornata nella mia stanza – lei non usciva mai e vagava per la casa indossando sempre una vestaglina leggera, in estate ma anche in pieno inverno, la stoffa punteggiata di fiori carnivori –, si era allungata al di là del mio letto, aveva guardato lo strappo e il buco. Poi mi aveva preso le mani tra le mani, aveva fatto passare i suoi polpastrelli sui miei, era uscita dalla stanza. Mia madre, avevo pensato quando ero rimasto solo, non proibisce, non autorizza, neppure si può dire che sorvegli. Mia madre è. Sta. È come l’aria, ma parla. Avevo sentito i suoi passi riformarsi in corridoio – ritornava –, la sua voce che già mi parlava prima di entrare in camera. Faria, aveva detto la madre ancora invisibile, nello sceneggiato non scava col dito. Faria, aveva detto la madre visibile rientrando in camera e avvicinandosi, scava con questo, e mi aveva allungato un pennino di legno e ferro, quello che se ne stava conficcato nel calamaio di peltro poggiato sul mobile all’ingresso. Poi mi aveva toccato la testa col palmo ed era uscita e io me n’ero rimasto con quello stiletto tra le mani, a fissarne la punta aguzza, a premerla piano contro la pelle delle dita. Quella notte lo scavo era stato bellissimo perché la punta del pennino penetrava l’intonaco con un suono animale; rannicchiato su un fianco non vedevo niente ma sentivo il verso dello scavo, un cricri che si trasformava in un picpic che a tratti, dove l’intonaco si faceva più umido, diventava uno squitsquit, io scavavo e dentro la parete c’era il grillo notturno, c’era il picchio, c’era il topo, io scavavo e inseguivo gli animali, li stanavo ma loro penetravano ancora più all’interno, in fondo, si nascondevano dentro la materia, cercavo di calcolare quanto spazio rimaneva ancora da bucare, davanti a me c’era sempre la superficie ma a un certo punto, pensavo, quegli strati infiniti dovevano finire, provavo a immaginare quanti altri colpetti microscopici del pennino erano necessari per trovare, per estrarre, per sbucare dall’altra parte, quanti raschi ancora, sentendo che più lo scavo avanzava più qualcosa – un midollo, un senso – si ritraeva, avanzare era indispensabile ma allo stesso tempo spingeva indietro, in dentro, il nocciolo, e dunque continuavo – cricri picpic squitsquit – e senza rendermene conto mi addormentavo con il pennino tra le dita, la polvere dell’intonaco sulle guance e sul naso, e poi al mattino mi svegliavo stanco, gli occhi secchi per la polvere assorbita, in classe me ne stavo in un costante dormiveglia, aspettavo solo che fosse di nuovo sera, cenavo, guardavo un’ora di tv e andavo a letto, mia madre mi salutava, spegneva la luce, io aprivo il cassetto del comodino, recuperavo il mio strumento e cominciavo a scavare, muovendo il polso il metacarpo e le dita che stringevano il pennino come se stessi scrivendo, non una frase che si allunga nello spazio ma una frase infinita che nello spazio penetra, io scavavo e scrivevo, tra la scrittura e lo scavo non c’era più nessuna differenza. Poi era arrivato un pomeriggio in cui dopo i compiti me ne stavo seduto sulla sponda del letto, le spalle allo scavo; mia madre era entrata nella stanza, si era allungata e aveva avvicinato un occhio al buco; mi ero girato a guardarla – i piccoli lembi della carta da parati che le sfioravano una guancia. Era rimasta lì, piegata in avanti, un ginocchio sul materasso, come se osservasse attraverso la lente di un binocolo; poi mi si era seduta accanto. Faria, mi aveva detto guardandomi, cosa pensi di trovare lì dentro? Io avrei voluto rispondere che non ne avevo idea ma non avevo fatto in tempo perché lei aveva subito proseguito, Vuoi trovare il coltello senza lama a cui hanno rubato il manico?, e io non avevo capito se mi stesse dicendo di continuare a scavare col coltello che stava nel cassetto in cucina, quello col manico rotto, ma quel coltello la lama ce l’aveva, stavo per chiederle di spiegare ma di nuovo lei mi aveva preceduto, Pensa a un coltello senza lama a cui hanno rubato il manico, aveva detto. Io ero stato zitto e l’avevo guardata – la mia madre d’aria, i fiori carnivori sulla sua vestaglina. Pensaci, aveva ripetuto, e senza darmi il tempo di dire qualcosa aveva chiesto Ci stai pensando?, e io avevo fatto cenno di sì con la testa, ma non pensavo niente. E lo vedi? Riesci a vederlo?, e io avevo detto Cosa?, e lei Il coltello senza lama a cui hanno rubato il manico, e allora io dentro la mia testa avevo materializzato un coltello, mi ero concentrato sulla lama che però non c’era e dunque l’avevo fatta sparire, poi mi ero spostato sul manico che però era stato rubato e quindi avevo fatto scomparire anche quello, avevo riprovato a vederlo ma di nuovo non ci ero riuscito – il coltello mi balenava nella testa e svaniva subito. Mi ero girato a guardare il buco, poi mia madre, lei si era alzata in piedi, mi aveva toccato il cranio con la mano: quando aveva staccato il palmo ed era uscita dalla stanza mi era sembrato che si fosse portata via per sempre il coltello. Nelle notti successive lo scavo era precipitato nel caos. Col pennino stretto tra le dita raschiavo l’intonaco, cacciavo il grillo il picchio il topo, continuavo a bucare, a scrivere la mia frase che penetrava nella materia, ma di colpo mi veniva in mente il coltello senza lama a cui hanno rubato il manico e allora tutto si indeboliva, si indeboliva la presa sul pennino, io spingevo i polpastrelli contro il legno ma sentivo il pennino che mi si smaterializzava in mano, il pennino svaniva e svanivano le dita il metacarpo il polso, smettevo di scavare e rimanevo disteso sulla schiena, gli occhi aperti nel buio, annusando l’intonaco polverizzato nell’aria – il visibile che diventava invisibile, il materiale immateriale –, perfettamente chiuso nella trappola di mia madre. E qualche giorno dopo mia madre era ricomparsa sulla soglia della camera. Sapevo che non veniva proprio da me, la mia stanza era solo una tappa della sua ronda diurna per la casa. Io ero appena tornato da scuola, me ne stavo seduto sulla sponda del letto; lei aveva mosso un passo verso di me, un altro, ancora uno: mi si era fermata davanti. Avevo sollevato il capo, avevo guardato i fiori carnivori che sbucavano dalla stoffa. Faria, aveva detto mia madre, come stai? Io avevo alzato ancora di più lo sguardo: mia madre mi fissava, le labbra socchiuse. Era come se a parlare fossero stati i fiori. Avevo riabbassato il capo. Faria Faria Faria, aveva detto un fiore. Se ne stava a qualche centimetro dal mio viso, era violetto, i petali larghi, gli stami bruni, e ondeggiava piano. Sapeva di bicarbonato. Come sta il mio abatino?, aveva domandato un altro fiore verde e blu, Come sta la mia talpina?, aveva aggiunto un gladiolo, Come sta oggi questo piccolo speleologo?, era la domanda del garofano, Come si sente il mio piccolo carotatore?, domandava ancora un fiore d’oleandro, Il mio carotino, Ti piace carotino?, fino a quando le voci si erano moltiplicate formando un fittissimo coro vegetale, un sussurro costante – Faria Faria Faria Faria Faria – che come un refolo scuoteva l’aria, un brusio sempre più forte che poi si era zittito di colpo. Nello stesso istante in cui era arrivato il silenzio, avevo sentito le mani di mia madre allungarsi piano – le dita lunghe e ramose – sul mio cranio. Faria, aveva detto mia madre attraverso la voce di tutti i fiori radunati sul suo corpo, tu scavi, scavi da giorni, hai scavato e scaverai, scavi perché ti piace e perché non ne puoi fare a meno, scavi perché arriva la sera e quando c’è il buio si scava, si scava il buio per uscire dall’altra parte, per sfondarlo e venire alla luce, e scavi perché ti piace muovere le dita come un insetto muove le zampe, ti piace brancolare, ti piace corrodere il muro col pennino, sgranocchiarlo, e allora devi sapere che lo scavo non finirà tra poco ma durerà nel tempo e che vivrai una vita di caverna, percepirai il giorno come uno sperpero di luce in attesa della notte, quando finalmente potrai accovacciarti sul tuo pagliericcio – perché tu dormirai su un pagliericcio – e metterti a scavare, un millimetro alla volta ti inoltrerai piano dentro la materia, ti crescerà la barba a groviglio, i capelli diventeranno lunghi e bianchi, le sopracciglia saranno un viluppo, scaverai e mangerai pane e qualche pesce e con le lische ti costruirai le penne, con il nerofumo mescolato al vino ti fabbricherai l’inchiostro e scriverai un libro sulle stoffa candida delle tue tre giubbe, estrarrai il sego dalla carne, lo brucerai, preserverai il fuoco con cui accenderai le tue steariche, e così, nelle pause dello scavo, studierai fino all’estinguersi del lumicino, non sarai mai pigro e imparerai cinque lingue, saprai tutto e non servirà a niente, sarai pacifico, sarai stupido, sarai nervoso, ignobile e meraviglioso, e non servirà a niente, penserai di essere l’erede di un tesoro nascosto in una grotta, la grotta nascosta nel punto più segreto di un’isola, e scavando, chiuso nel tuo cunicolo, romperai per un attimo il silenzio esclamando Hic Thesaurus, e le notti passeranno sotto le pietre del camminamento, sempre a scavare, fermandoti solo quando sentirai o immaginerai di sentire i passi delle sentinelle sopra la tua testa, e ancora passerà la notte, tornerà il giorno con il suo sperpero di luce e poi di nuovo la notte e tu vagabonderai nella materia, fino a quando – ed è giusto che adesso tu sappia anche questo – calcolerai male una curva e sbaglierai – ma non c’è alternativa, le fatiche sono tutte sprecate, le fatiche sono tutte indispensabili e sprecate: ed è sprecata, sempre, la scrittura – e così, dopo anni e anni di lavoro, quando avrai immaginato di essere infine sbucato dall’altra parte, ti renderai conto di essere solo passato dalla tua cella di prigioniero alla cella di un altro prigioniero, evaderai nel dentro – e mai mai mai ti sarà dato il fuori, mai un’estroversione: il fuori, tagliare la tela e uscire dal sacco, è solo e sempre il destino degli altri –, così diceva mia madre, il coro di fiori sul corpo di mia madre, la mia madre oracolare, la mia madre febbrile e bugiarda, la mia madre visibile e invisibile, le sue mani sul mio cranio, il calore dei palmi e poi una pressione che aumenta, le dita di mia madre che entrano dentro la mia testa e vengono fuori, mia madre che mi tocca la guancia e si ritrae, io le guardo le mani cercando con gli occhi il coltello senza lama a cui hanno rubato il manico, non lo vedo, non c’è e quindi c’è, è nelle sue mani, è materialmente immateriale, e poi sulla soglia della camera mia madre si ferma e riprende a parlare. Faria, dice, tu vivrai tutta la tua vita da clandestino, talmente che da adulto ti sembrerà di aver trascorso il tempo non semplicemente chiuso in un cunicolo ma nascosto nel ventre di una nave che attraversa silenziosa l’oceano nero, senza mai poter sapere che cosa succede lassù, in alto, sul ponte di comando, se c’è ancora qualcuno o se intanto se ne sono andati via tutti, aspettando solo che la vita clandestina abbia fine, e a quel punto mia madre era già in corridoio e le sue ultime parole prima che la voce svanisse erano state Ma tu Faria continua a scavare continua a scavare continua a scavare, e allora io avevo aperto il cassetto del comodino, avevo frugato al suo interno, avevo tirato fuori il pennino, mi ero girato a guardare il buco, ero rimasto fermo. Quella notte mi ero rigirato a lungo nel letto; poi mi ero addormentato, avevo sognato. Nel sogno penetravo nella parete, e il suo interno non era nero ma bianco e sapeva di bicarbonato, io scavavo e subito oltre la superficie che grattavo col pennino sentivo un crepitio sottile, e bisbigli e fruscii, e nel sogno sapevo che erano il grillo il picchio e il topo che fuggivano lentissimi nella direzione opposta allo scavo, o forse la loro non era una fuga, forse il grillo il picchio e il topo mi stavano solo precedendo nello scavo, armoniosi o sparpagliati, anche loro in cerca di una fenditura dalla quale evadere, o forse, ancora, il grillo il picchio e il topo stavano giocando, io scavavo e loro giocavano a inseguirsi, folli e sereni, nella materia cieca – e scavando io ero il grillo, il picchio, il topo. La mattina dopo mi svegliai prestissimo, ancora in pigiama percorsi il corridoio pieno di luce; in cucina, sul tavolo di formica, c’era la mia tazza; nella tazza, il latte che fumava. Sapevo che mia madre era già sveglia – mia madre non dormiva mai – ma non avevo idea di dove fosse: in casa, perché lei era sempre in casa, ma pellegrina per le stanze. Non la incontrai neppure quando dopo essermi lavato uscii dal bagno e tornai nella mia stanza, neppure quando mi vestii e preparai la cartella. Il corpo di mia madre taceva in giro per casa. Quando fui pronto per andare a scuola, mi fermai accanto al letto e rimasi a osservare i lembi della carta da parati aperti e, subito oltre quella corolla, il caos minerale del mio cantiere permanente, gli intagli che solcavano l’intonaco intorno al buco, ogni intaglio un collaudo, e poi l’inoltrarsi profondo del cunicolo, o almeno di quello che io continuavo a vedere come un cunicolo, il frutto di notti e notti di lavoro, di notti e di anni, di decenni dei quali avevo ormai perduto il conto, e all’improvviso, davanti alle macerie nude, elementari e nude, davanti a quel piccolo inutile sfacelo di intonaco polvere e tritume, avvertii un prurito al viso, mi toccai e sentii la barba che mi germogliava sul mento e sulle guance – la toccai, era dura come un cespo; la allungai fino a vederla: era bianchissima – e sulle spalle mi si allungarono i capelli, anche quelli aridi e aspri, mi toccai il viso e sentii le ossa degli zigomi e della fronte, la pelle calcarea, le sopracciglia aggrovigliate, e allora mi guardai le mani, i palmi sporchi di nerofumo, le annusai e sapevano di vino, avrei voluto trovare uno specchio ma non serviva, mi specchiavo nelle mani e nello spazio, nelle rovine modeste del mio cantiere. Ero Faria. Io ero Faria. Il bambino vecchissimo e paradossale, il piccolo farneticatore, Faria, l’apprendista clandestino – e mentre pensavo e sentivo e mi commuovevo davanti alle macerie del mio futuro, mia madre entrò nella stanza, mi toccò la testa infilandomi le dita nella sterpaglia dei capelli, poi mi prese per mano e mi accompagnò verso la soglia della camera, la vestaglina che si scuoteva piano, i fiori teneramente carnivori, e quando stavamo già percorrendo il corridoio invaso di luce sentii un rumore e mi fermai, mia madre continuò a procedere tranquilla e perduta nella sua ronda e io tornai indietro in tempo per vedere, nella stanza vuota dove il pulviscolo oscillava piano nell’aria, il cunicolo bianco subito sopra il letto e il grillo il picchio e il topo venire fuori dallo scavo, guardarsi per un momento intorno e di nuovo sparire veloci dentro la materia.

Via Sciuti, Palermo, Sicilia. Foto scattata tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70.

Cartolina di Via Sciuti, Palermo, Sicilia, 1951.

Quartiere Libertà a Palermo, Sicilia, posto cruciale per la maggior parte degli omicidi di Mafia avvenuti negli anni '80.