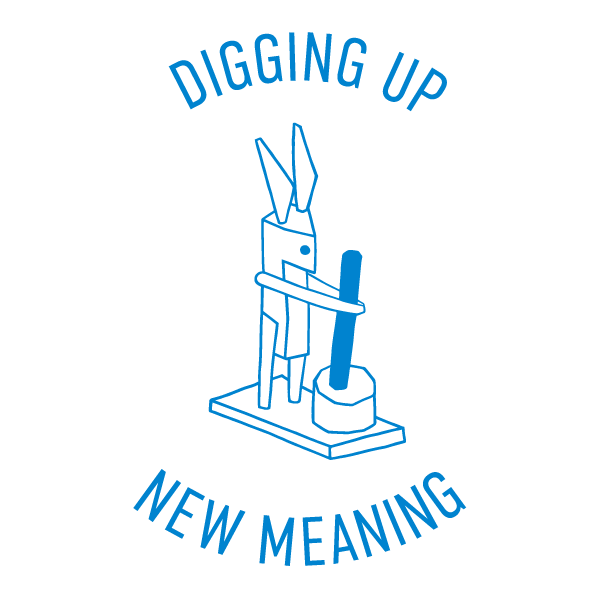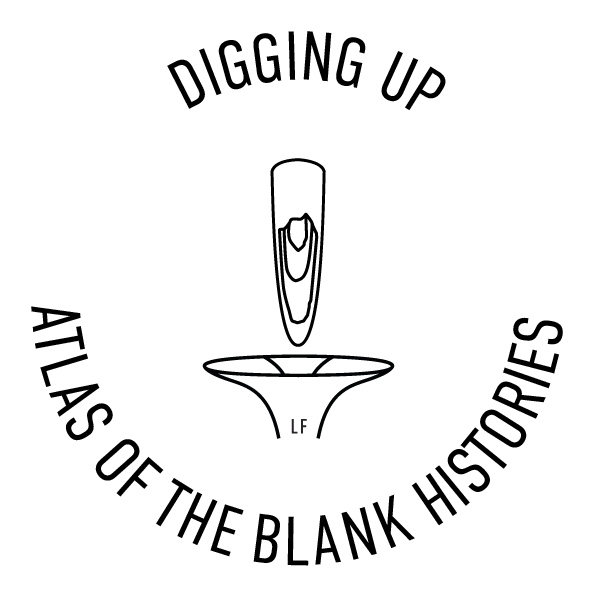Pompei, Casa Bacco (VII 4, 10), deposito del Parco Archeologico di Pompei. Courtesy Parco Archeologico di Pompei. Photo Amedeo Benestante
“C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira [...] Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò̀ che chiamiamo il progresso, è questa tempesta”
Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia (tesi IX), 1940
“Napoli è la più misteriosa città d’Europa, è la sola città del mondo antico che non sia perita [...]. Napoli è una Pompei che non è mai sepolta. Non è una città: è un mondo. Il mondo antico, precristiano, rimasto intatto alla superficie del mondo”
Curzio Malaparte, La pelle, 1959
Una disciplina che non c’è.
Come scrisse il filosofo Walter Benjamin – forse il più “frammentario”, sia per stile di scrittura che per struttura del pensiero, e quindi anche forse il più “archeologico” fra i pensatori della modernità – il tempo moderno sarebbe ancora dominato da coordinate preistoriche e inconsce, quali la natura e il mito, che tendono a rigenerarsi continuamente anche nella mercificazione e omologazione del presente e dell’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica1. Quelle del presente sono quindi “macerie”, definite da un eterno ritorno, una coazione a ripetere dei formati predefiniti di esperienza. Paradossalmente solo la memoria potrebbe emanciparci da questo stato – ovvero non l’essere costretti a procedere in avanti, ma la possibilità di guardare indietro – una volta che essa fosse intesa come esperienza ermeneutica che miri a riavvicinare e a riarticolare fra loro temporalità ed eternità, nella sfera individuale e collettiva. Dissotterrare la realtà storica per rivelarla a se stessa riscoprendo la struttura sotto i frammenti e decifrando i brandelli della fattualità storica che la coscienza soggettiva tende a conservare e reiterare. Procedendo quindi oltre l’Erlebnis esplorata da Wilhelm Dilthey e i limiti della “durata reale” della coscienza volontaria esplorata da Henri Bergson, Benjamin ci consegna una memoria come necessità di oltrepassare le narrazioni protettive di matrice psicanalitica o quelle standardizzate del consumo, accogliendo la complessità del palinsesto memoriale che emerge nel contemporaneo dal flusso della storia.
Potremmo dire che Benjamin è stato uno dei primi viaggiatori nel tempo, pur senza saperlo, e le implicazioni dell’invenzione di una “macchina del tempo” ante-litteram potrebbero contribuire a spiegare l’analoga esperienza che produsse la riscoperta, alla metà del XVIII secolo, di Pompei, Stabia e Ercolano: un tempo obliato che tornava a coesistere nel tempo presente, uno spazio obliterato che riaffiorava sotto lo spazio che abitiamo e percorriamo e crediamo quindi di conoscere, un’altra storia che torna a essere raccontata nel corso stesso della nostra storia. Introducendoci in una dimensione sincronica del tempo e relativista dello spazio, e quindi auto-critica della realtà, Pompei funse da cortocircuito intellettuale della modernità in essere: chissà cosa sarebbe successo se invece di scriverne ad horas Johann Joachim Winckelmann o Johann Wolfgang Goethe, Madame de Staël, François-René de Chateaubriand o Stendhal, Pompei fosse stata scoperta un secolo dopo e ne avessero scritto ad horas Sigmund Freud, Albert Einstein, Karl Marx e, appunto, Walter Benjamin; o due secoli dopo, e ne avessero scritto gli autori delle teorie tracciate dalla fisica quantistica – teoria delle bolle, teoria delle stringhe, concezioni del multiverso e del Big Bounce, che esplorano universi “oscillanti”, “pulsanti”, “paralleli” e infinitamente molteplici, ma inevitabilmente quanto fantasticamente connessi fra loro (entangled).
Sigmund Freud visitò per altro Pompei nei primi anni del XX secolo e sarebbe interessante approfondire , nei suoi scritti, il parallelismo fra processo psicanalitico e processo di scavo archeologico. Un esempio è fornito dalla sua interpretazione della novella del 1903 Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück di Wilhelm Jensen, “fantasia pompeiana” che narra la storia di un archeologo, Norbert Hanold, che dopo aver osservato in un museo un bassorilievo che rappresenta una figura femminile se ne procura una copia in gesso. Attratto dall’immagine di quella da lui soprannominata Gradiva (“colei che risplende nel camminare”), immagina in sogno di vivere con lei nell’antica Pompei, dove la ragazza rimarrà vittima dell’eruzione. Ma, nella dinamica fra dimensione onirica e analisi cosciente, riesce a liberarsi dell’ossessione verso questa figura sospesa fra rimozione e rivelazione (“di quale essenza fosse l’apparenza corporea di un essere, come Gradiva, contemporaneamente morto e vivo, anche se vivo solo durante l’ora meridiana degli spiriti”), e a sostituirla con una donna reale, il cui ricordo infantile era rimasto sopito sotto il riverbero iconografico della camminata della ragazza di pietra pompeiana2.
Del resto proprio le opere e i manufatti di Pompei sembrano realizzare quanto Benjamin scriveva sul valore epifanico e liberatorio delle immagini “dialettiche” nelle sue Tesi di filosofia della storia, scritte proco prima del suicidio del filosofo in fuga dal regime nazista. L’immagine è “dialettica” nel senso che nella sua immobilità sovverte il decorso consequenziale fra passato e futuro, procedendo in modo discontinuo, a salti, avanti e indietro, e condensando quindi l’autenticità intimamente stratificata del pensiero: “Il pensiero si arresta di colpo in una costellazione satura di tensioni, le impartisce un urto per cui esso si cristallizza in una monade”3. Mentre il pensiero tende infatti a dispiegarsi, l’immagine ne costituisce la “piega”, il momento esatto di una delle sue piegature in cui la memoria conserva il dinamismo dialettico delle sue componenti plurime, in uno stato provvisorio di quiete rivolto tanto al passato che cita quanto al futuro a cui si consegna4.
Riferendosi anche all’atlante della memoria di Aby Warburg, il Bilderatlas Mnemosyne dedicato alla riproposizione delle immagini antiche nella cultura europea moderna, così come alla mémoire involontaire della recherche di un temps perdu di Marcel Proust, o alla piccola tela di Paul Klee che gli ispira il testo sull’Angelus Novus, Benjamin analizza la capacità dell’immagine dialettica sia di spezzare il destino irreversibile e teleologico della citazione sia di sprigionarne polisemia, potenzialità e ipoteticità, e quindi l’intima qualità rigeneratrice, l’essere matrice di possibili narrazioni ulteriori. È, questo, l’approdo all’Erfahrung, un’esperienza di coalizione fra passato e presente, soggetto e oggetto in cui tutto è già avvenuto e al contempo può ancora avvenire, in cui il soggetto può ancora definire la sua posizione rispetto all’oggetto, al contempo prodotto e da prodursi, in cui ogni termine della relazione è tale ma simultaneamente libero, in una prossimità in cui i soggetti e gli oggetti del passato godono di un’esistenza postuma a se stessi nel loro incontro con l’alterità fluida di un tempo futuribile che li accoglie in sé per raccontarne, ancora e in altri modi, la storia.
Se ci riferiamo all’antichità, questa è del resto una storia in gran parte di copie, di repliche, di originali perduti, come scrive Salvatore Settis, nello smisurato naufragio dell’arte antica, ed esperibili quindi solo dalla trascrizione sinestetica delle fonti, per altro anch’esse parziali o non necessariamente fedeli, o attraverso il sovrapporsi di ricostruzioni progressive e interpretazioni multi- soggettive, e per questo potenzialmente fra loro incoerenti. La storia quindi del perdurare fantasmatico di un canone, la cui influenza, dettata del desiderio di un’esperienza simile all’originale, seppur delocata nello spazio e differita nel tempo, trasmuta – ovvero si trasmette cambiando forma e supporti pur mantenendo le ragioni e la riconoscibilità della struttura originaria. Esperienza che trasmutò, innanzitutto, dalla Grecia a Roma, come poi dall’Europa medioevale a quella rinascimentale e quella moderna, attraverso una serie di riproduzioni miniaturizzate e portabili, attraverso una serie di sviluppi del gusto e delle tecniche, fenomeni di moda, illusioni ed errori. Quali quelli dell’estetica neoclassica che conferiva un’aura a ciò che in origine poteva essere un mero oggetto funzionale, o un immaginario candore a ciò che in origine poteva avere una cromia pre-Pop. Del resto ogni epoca ha reinventato la sua definizione di classico, entità la cui taratura ha a che fare tanto con il passato quanto con il presente e il futuro, in una spirale potenzialmente infinita che giunge fino a oggi, e oltre, fra i gadget kitsch del turismo di massa e la proposta di esperienze digitali, virtuali, immersive: che, nel loro insieme, profilano una classicità contemporanea al contempo documentaria e, paradossalmente, fictional5.
Come studiare quindi Pompei da questo punto di vista critico e narrativo? Occorre forse una disciplina che non c’è, o che si dà̀ solo all’incontro fra i concetti e le immagini di cui ho finora parlato e di cui la mostra Pompei@Madre. Materia Archeologica si propone come possibile rievocazione e narrazione ulteriore6.
Che cos’è la “materia archeologica”? Accenni per un metodo.
Con la definizione “materia archeologica” si intende, all’interno del metodo delineato e declinato in questo progetto, innanzitutto la disciplina in sé dell’archeologia (dai termini greci per “antico” e “studio”): ovvero la ricerca sulle civiltà antiche attraverso lo scavo, la conservazione, la catalogazione, la documentazione e l’analisi di reperti – posti in relazione all’ambiente del loro reperimento – quali architetture, opere d’arte, manufatti d’uso comune, resti organici e inorganici.
Ma la natura frammentaria degli oggetti di studio archeologici – che obbliga a una visione olistica, ovvero alla coalizione fra quelle discipline che, in modo interdipendente, concorrono a ricomporre la frammentarietà documentale in un’unità ipotetica e a trasformare tracce oggettive in una storia possibile – rendono la “materia archeologica” una disciplina potenzialmente e radicalmente anche contemporanea. Il fatto stesso che l’archeologia debba, per recuperare il passato, agire nel presente, secondo un processo aperto all’intuizione e all’interpretazione, suggerisce questa affascinante prossimità fra archeologia e contemporaneità, introducendoci all’intreccio (analogo all’entanglement della fisica quantistica già citato) fra componenti culturali e naturali, fra categorie estetiche e funzioni d’uso, fra teoria e pratica, fra scienze umane e scienze dure.
Un palinsesto che, oscillando fra spazi e tempi diversi, stimola un approccio multidisciplinare aperto all’eventualità dell’invenzione come al rischio dell’errore, e quindi alla costante ridefinizione delle proprie metodologie, dei propri strumenti di indagine, dei propri giudizi, del concetto stesso di cosa significano “spazio”, “tempo”, “storia” e “realtà”.
Inoltre la prospettiva temporale estesa che l’accostamento fra archeologia e contemporaneità evoca permette di rivelare ed esplorare l’intima fragilità, la natura effimera e il destino entropico di ogni opera d’arte, di ogni civiltà e di ogni cultura (e quindi della storia umana stessa): destinate non solo a essere sostituite da nuove opere, civiltà e culture ma a confrontarsi, nella loro consistenza storica, da un lato con la loro origine naturale e dall’altro con la loro destinazione finale, nell’ambito nuovamente dell’ecosistema naturale. Queste pietre provenienti da Pompei, che recano la memoria delle sculture che furono, e in parte sono ancora, come queste polveri di colore, che conservano tracce degli affreschi a cui appartenevano, suggeriscono i contorni mobili di una rigenerazione permanente: prima di divenire un oggetto artistico ognuna di queste sculture è stata una pietra, così come ogni affresco è stato polvere di colore tratto da conchiglie, frutti, radici o fonti minerali. Sotto la loro temporanea pelle estetica, alla natura essi quindi ancora appartengono, così come alla natura questi frammenti si richiamano, presagi del loro destino nel flusso del tempo.
Nella sua stratigrafia culturale e naturale Pompei rappresenta quindi, epistemologicamente, un laboratorio straordinario in cui il tempo, per secoli, si è fermato restituendoci – nella fragranza di un rapporto quasi di prossimità con il passato remoto – frammenti che sono indizi di una civiltà scomparsa ma resiliente: vera e propria macchina del tempo che, riconsegnandoci la storia di innumerevoli materie immerse nel flusso del tempo storico e naturale, sfuma la differenza fra passato e presente, natura e cultura, vita e morte, distruzione e ricostruzione.
Per questo il percorso della mostra Pompei@Madre. Materia Archeologica è concepito e strutturato come una perlustrazione circolare fra opere, manufatti, documenti e strumenti connessi alla storia delle varie campagne di scavo a Pompei – che ricostruiscono per accenni la vita quotidiana della città antica e il ruolo che in essa rivestivano le arti e le scienze – messi a confronto con opere e documenti moderni e contemporanei. Provenienti da collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali7, ognuna di queste opere e documenti ha continuato a rivendicare, a partire dalla riscoperta del sito nel XVIII secolo, il valore e l’ispirazione contemporanei della “materia archeologica” pompeiana fungendo da vettore fra spazi, tempi e culture differenti, continuando a metterli a confronto fra loro. Ed è per questo che in questa mostra si coniugano, anche solo per accenni, arti visive, letteratura, musica, teatro, cinema ma anche storiografia, cartografia, paleontologia, antropologia, biologia, botanica, zoologia, chimica, fisica, genetica, nonché l’esteso campo delle nuove tecnologie. Nel tentativo di definire ipotetici paralleli che attraversano la storia antica, moderna e contemporanea, si racconta la storia di una “materia” che rivela la reciproca implicazione fra materiali originari e opere d’arte risultanti, in transito fra iconografie, concetti ed esperienze che tornano ad affiorare, nella storia della cultura e dell’arte, come immagini “dialettiche” di benjaminiana memoria.
A partire infatti dall’eruzione del 24 agosto del 79 d.C. – che con la sua nuvola di gas a forma di pino, descritta da Plinio il Giovane nelle sue lettere a Tacito, ne decretò una dormienza millenaria – e soprattutto dopo la sua riscoperta nel 1748 (che segue quella di Ercolano, dieci anni prima) Pompei si è trasformata in un enorme repertorio di immagini “dialettiche”, portale spazio-temporale che mette in comunione elementi fra loro distanti. La sua materia è stata da allora soggetta a ulteriori catastrofi – come i danneggiamenti subiti a causa dei bombardamenti anglo-americani durante il secondo conflitto mondiale, a partire da quello del 24 agosto del 1943 – spettro e monito di analoghe drammatiche distruzioni precedenti o successive: come, fra queste ultime, quelle inferte dal regime talebano al Museo Archeologico di Kabul e ai Buddha di Bamiyan, da al-Qaeda all’antica moschea di Timbuktu come alle Twin Towers di New York, da Daesh ai siti di Nimrod e Palmira, alle collezioni del museo di Mosul, a antiche opere d’arte bizantina e islamica a Raqqa e Ninive. Ma questa materia è stata catalizzatrice di altrettante ulteriori rigenerazioni, disponibile a ulteriori attraversamenti ea nuove vite.
È proprio la storia di questa “materia archeologica”, al contempo fragile e combattiva, archetipica seppur così effimera, che ha permesso a Pompei di continuare a essere contemporanea, con il suo processo in fieri che ha accompagnato la modernità, ed è questa la storia di questa mostra, così come è su questa perdurante contemporaneità di Pompei che il metodo di ricerca che ne è alla base si è potuto definire. Pompei ha testimoniato d’altronde questa sua contemporaneità già a ogni viaggiatore del Grand Tour, in un frenetico scambio di lettere, redazione di diari di viaggio, produzione di schizzi, tavole disegnate, volumi a stampa. A Goethe, che nel 1787 scriveva che “di tutte le catastrofi che si sono abbattute sul mondo, nessuna ha provocato tanta gioia alle generazioni seguenti”, sembra rispondere nel 1804 Chateaubriand, quando visita “una città romana conservata nella sua interezza, come se gli abitanti fossero andati via un quarto d’ora prima”. Ed è a questa sensazione di affinità elettiva, addirittura epidermica, forse più irrazionale che razionale, che è possibile attribuire la profonda influenza che Pompei ha esercitato in tutta l’epoca moderna su intellettuali di differenti provenienze e formazioni: dalle visite di Gustave Flaubert nel 1851, Théophile Gautier nel 1852 (“A Pompei due passi separano la vita antica dalla vita moderna”), Alexandre Dumas nel 1860 o dello storico Hippolyte Taine nel 1864 (“l’immagine della città grigia e rossiccia... con le sue file di muri spessi e di basoli bluastri, nell’aria smagliante di candore; intorno, il mare, le montagne e l’orizzonte infinito”) a quelle di Jean Cocteau, Pablo Picasso, Sergej Djagilev, Léonide Massine e Le Corbusier, che nei suoi disegni in mostra sembrerebbe riferirsi alle caratteristiche biodinamiche che furono già proprie della domus pompeiana – al suo equilibrio fra interno ed esterno, componenti architettoniche e rapporto con l’ambiente circostante – più che alla retorica simbolica e antidemocratica dei monumenti romani8. E proprio a Le Corbusier riconosciamo di aver ispirato il progetto stesso di allestimento della mostra Pompei@Madre. Materia Archeologica.
Lo spazio-tempo circolare di una mostra (una possibile guida breve).
La mostra si articola infatti in un percorso circolare – evocativo di una concezione ciclica e cairologica del tempo di matrice appunto greco-romana – ma anche dialogante fra interno ed esterno, composto da suggestioni fra loro liberamente associabili e ritornanti su se stesse, come perlustrando possibili varianti del già noto. Che innanzitutto rimettono in prospettiva le opere della collezione di Palazzo Donnaregina, trasmutata per un intero anno in una vera e propria domus contemporanea. Dall’ingresso di Daniel Buren (Axer/Désaxer, 2015) – vestibulum e atrium, ma anche peristylium mosso dal suo stesso asse interno fino a dialogare con la strada all’esterno – alle sale site-specific del primo piano, con il cui il museo MADRE inaugurava nel 2005: l’epigrafe di Domenico Bianchi si confronta con epigrafi scritte in latino sui muri della città antica, come “storie nella storia”; la sala affrescata e decorata di maioliche pavimentali di Francesco Clemente diviene tablinum e triclinium, fulcro della domus, la sala di rappresentanza del dominus e la sala dei ricevimenti e dei banchetti; lo sguardo alla volta celeste di Luciano Fabro, con le sue costellazioni e le sue mitologie, riporta a una relazione con la dimensione astrale, con ciò che nel cielo risiede e che dal cielo può cadere per manifestarsi sulla terra, divenendo l’apparizione inusitata del profilo di un compluvium che si specchia in un impluvium; tutto il tema del viaggio di Jannis Kounellis sembra riverberarsi in un mosaico pavimentale gremito di creature marine che, circondando una grande ancora, collocano la comunità antica nel caleidoscopio dei suoi peripli di esseri umani, di merci e di storie; mentre il rapporto fra figurazione e astrazione proprio delle decorazioni ambientali pompeiane si espande nelle sale di Sol LeWitt e Jeff Koons, i lacerti di pitture parietali e di decorazioni scultoree echeggiano nelle sale di Giulio Paolini e Richard Serra; e se la sala cosparsa di fango di Richard Long suggerisce la necessità quotidiana di un rapporto con la materia viva di una cucina (culina), le capuzzelle di Rebecca Horn, con i loro riferimenti folklorici allavanitas e memento mori partenopei, riportano in superficie un culto degli antenati (Lares e Penates) e una memoria dei defunti che si approfondisce ulteriormente nella dimensione sotterranea, ctonia del buco nero nel pavimento di Anish Kapoor. In questa sequenza di camere la sala di Mimmo Paladino sembra idealmente ospitare, infine, il sonno di un cubiculum: dove giace, in un immoto fremito, il calco di due dei tanti dormienti – un padre con il suo bambino? – dell’antica Pompei.
Al terzo piano la suddivisione per sale della mostra procede prescindendo analogamente da un criterio cronologico, come una narrazione in capitoli in cui ogni opera, a prescindere da datazione, provenienza o caratteristiche, si richiama alle altre poste in sala. Il percorso è introdotto dalla presentazione di alcuni giornali di scavo (1780; 1853) e dal primo dei diari-regesto che documentano le distruzioni avvenute nel 1943, circondati da strumenti del lavoro quotidiano degli archeologi (pale, picconi, pennelli, ceste, setacci, squadre da cantiere, lanterne, insegne e portantine) e da una cartografia che mostra una veduta aerea di Pompei realizzata nel 1910 con un pallone aerostatico. Il centro della sala è dominato dalla presenza di alcuni massi su cui, come superfetazioni, crescono e prendono forma alcuni elementi organici o inorganici: sono le opere di Adrián Villar Rojas, che suggeriscono un primo cortocircuito fra plausibile e implausibile, in cui invece di un ritrovamento archeologico... ciò che ci appare di fronte è un’opera contemporanea.
Dopo una vetrina-libreria in cui è raccolta la storia bibliografica della fascinazione verso la “materia archeologica” pompeiana nel corso di più di due secoli e mezzo di Grand Tour, e che comprende anche testi recenti su Paweł Althamer e un’opera testuale di Darren Bader, la mostra si sussegue con sale in cui i documenti moderni – stampe acquerellate, fotografie, oggetti d’arredo, manufatti unici o moltiplicati (veri e propri multipli d’epoca) – si integrano con frammenti e manufatti archeologici e opere contemporanee. Le acquetinte della serie Vues pittoresques de Pompéi di Jakob Wilhelm Hüber, allievo del pittore Jacob Philipp Hackert e figura seminale per la genesi della Scuola di Posillipo, procedono verso le stampe di recupero di Roman Ondák in cui l’artista inserisce, più di due secoli dopo Hüber, un suo impossibile autoritratto a matita quale testimone degli stessi eventi eruttivi passati. Nella sequenza fotografica di immagini d’archivio che documentano il susseguirsi delle campagne di scavo pompeiane irrompe la teoria delle colonne di Basilica I e Basilica II di Victor Burgin, il cui soggetto è a sua volta contraddetto e allo stesso tempo riaffermato dalle materializzazioni tridimensionali e fantasmatiche della colonna spezzata da Maria Loboda, della base bianco-oro di Iman Issa e del profilo architetturale di Rita McBride. Si portano in primo piano decorazioni parietali e musive che, con i vari stili pompeiani di rappresentazione illusiva, si offrono al punto di vista della camera fotografica analogica di Luigi Ghirri, Nan Goldin e Mimmo Jodice, dell’arazzo generato digitalmente di Laure Provost o alla prospettiva compendiaria del bassorilievo in ceramica di Betty Woodman, che sembra plasmato con la stessa curiosità che anima due copie moderne, rispettivamente disegnata a matita su carta e realizzata in terraglia a rilievo, del grande mosaico raffigurante Alessandro Magno alla battaglia di Isso. Gli schizzi e gli studi di dettagli architettonici eseguiti da Claude-Ferdinand Gaillard, Pierre Gusman, Jules-Leon Chiffot fra il 1861 e il 1927 si combinano con frammenti di domus originarie, mentre il teatrino di Fausto Melotti sorretto dalla struttura metallica in rosso pompeiano di Thea Djordjadze fa da sfondo a due biscuit della Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte e un’opera in pietre dure coeva che replica il Tempio di Iside, il primo santuario rinvenuto integro a Pompei, nel 1764. E se una parete dell’affresco del Bracciale d’oro è raffrontata da una parete in vernice argentea spruzzata con un idrante e solcata dalle piccole tele di Pádraig Timoney, le eteree installazioni ambientali di Haris Epaminonda sembrano richiamate dalle ciotole con polveri multicolori rinvenute a Pompei o da uno dei loro prodotti finali, un affresco staccato che mostra una figura femminile (la dea Venere) inquadrata da due ghirlande vegetali e portata in trionfo da un gruppo di elefanti.
La sala centrale della mostra si apre invece su una serie di vedute della campagna vesuviana, con il vulcano in eruzione: un’eruzione che – come in un piano-sequenza cinematografico che riprende in una panoramica circolare l’intera sala – sembra continuare ininterrotta dalla metà del Settecento, con vedute di epoca neoclassica, romantica e naturalistico-verista (da Johan Christian Dahl, Joseph François Désiré Thierry, Pierre-Henri de Valenciennes e Pierre-Jacques Volaire a Gioacchino Toma) fino gli anni ottanta del XX secolo con un esemplare dei Vesuvius by Warhol, per fermarsi provvisoriamente all’anno stesso della mostra (2017) con l’opera Untitled di Wade Guyton. Al centro della sala – in un silenzioso confronto con le opere su marmo e in pietra di Trisha Donnelly e Christodoulos Panayiotou da cui affiorano accenni di un’ipotetica figurazione – sono collocati, in due grandi vasche-deposito, cumuli di “materia archeologica” pompeiana lapidea e ceramica, a dare rappresentazione al flusso di questa materia fra epoche, mezzi, stili e sensibilità differenti ma coesistenti. La sala adiacente ospita del resto, su un pavimento in creta di Petra Feriancová, materie pure in trasformazione, dall’assemblage di Robert Rauschenberg Pompeii Gourmet al disegno che registra la caduta di polveri vulcaniche di Renato Leotta e al pneumatico-foglia di Mike Nelson.
Dopo una sala dedicata a una museografia congetturale e immaginifica – affidata al peep-show e alle vetrine hamiltoniane di Mark Dion, mischiate a reperti reali e oggetti moderni e inquadrate dal “pittore di fuoco” di Ernesto Tatafiore – le sale successive si svolgono come un epicedio dedicato alla morte: la morte di ogni cosa, di ogni essere umano e di ogni forma di vita sotto la pioggia di lapilli, gas e ceneri del 79 d.C. In una diacronia rituale che livella apparentemente tutto, dall’ufficio fossilizzato di Jimmie Durham si procede ai documenti di Operazione Vesuvio – con cui il critico e curatore Pierre Restany propose nel 1972 a vari artisti di trasformare l’area vesuviana in un “parco culturale”, una gigantesca opera di Land Art –e all’identificazione fra terra e cielo nella tela ruvida, dipinta da Salvatore Emblema alle falde del Vesuvio, che li accoglie entrambi. Da un armadio-ossario proveniente dai magazzini di Pompei si procede ai giganteschi profili stanti su teschi immacolati del Terrae Motus di Nino Longobardi, ai crani/pani in bianco e nero di Antonio Biasiucci, al bassorilievo in materiale plastico di un bomber bianco di Seth Price, alle sedute-impronte corporali di Nairy Baghramian. E dal calco del “cane di Pompei” – tecnica, quella del calco, messa a punto e pubblicizzata fra il 1863 e il 1868 dall’allora Direttore di Pompei, Giuseppe Fiorelli – si procede alla sua moltiplicazione seriale a opera di Allan McCollum e alle vetrine con uccelli multi-materici in progressivo e lento disfacimento di Roberto Cuoghi. Ma è a questo punto che compare, in una vetrina climatizzata, una tassonomia di materiali organici, i resti di quella vita che a Pompei rimase sepolta, carbonizzata, frammentata, ma non annichilita: semi, arbusti, frutti, conchiglie, ossa, uova, pani, tessuti. È dal DNA di quella vita, pazientemente raccolta e sapientemente studiata da archeologi, agronomi e botanici, antropologi e zoologi, chimici e fisici, che la vita a Pompei potrebbe letteralmente rinascere, dalle sue stesse ceneri. Come sembrano suggerire i vasi zoomorfi e la maschere antropomorfe rinvenuti anch’essi a Pompei e a cui sembra ispirarsi, attraverso l’ipotetica mediazione del vaso-rovina di Ettore Sottsass, Goshka Macuga nel ripercorrere la storia del “secolo breve” appena concluso, affidandola alle sue più rivoluzionarie icone intellettuali della modernità, dalle cui teste germogliano fiori.
Ed ecco che infine (ma in realtà là dove il percorso in loop della mostra si riallaccia al suo inizio) a Maria Thereza Alves è affidato il compito di prelevare alcuni semi da un vero e proprio giardino – che cresce nell’ultima sala della mostra, secondo uno schema rinvenibile anche nel collage di Bill Beckley installato nei pressi – da cui cresceranno non solo nuove piante ma, rintracciando l’origine storica di quegli stessi semi e quindi la loro meticcia matrice multi-culturale, nuove storie, ancora da raccontare.
Ipotesi per un finale aperto…
Il progetto comprende del resto un finale aperto, in ogni senso, corrispondente a un musée imaginaire, un “museo senza muri” (ma anche senza epoche) come quello profetizzato nel 1947 da André Malraux9, o come quello a cielo aperto vagheggiato dai viaggiatori del Grand Tour. A partire dal prossimo futuro sarà̀ infatti dato possibilmente avvio a un progetto che permetterà l’utilizzo di “materie archeologiche” di provenienza pompeiana per la commissione, concezione, produzione e diffusione di nuove opere d’arte contemporanea: Pompeii Commitment. Materie Archeologiche.
Edward Bulwer-Lytton fu l’autore, nel 1834, di un romanzo divenuto poi fonte di ispirazione di numerose trasposizioni cinematografiche10 intitolato Gli ultimi giorni di Pompei. Eppure, a questo punto, potremmo domandarci: e se, con il suo lascito di “macerie” storiche, culturali e naturali, organiche e inorganiche, minerali, vegetali, animali e umane, quelli non fossero stati in effetti solo gli “ultimi” giorni di Pompei ma anche i “primi” di una nuova, di un’altra Pompei: la nostra? L’emancipazione rigenerativa di Pompei sembrerebbe dimostrata da una sequenza del film Viaggio in Italia (1954) di Roberto Rosellini, in cui una coppia di mezza età in crisi, Alex e Katherine Joyce (interpretati da George Sanders e Ingrid Bergman), visitando l’area archeologica di Pompei assiste allo scavo del calco di una coppia abbracciata: immagine di una comunione al di là del tempo e dello spazio che li sospinge a un possibile riavvicinamento.
Immagine che potremmo definire anch’essa “dialettica”, per riprendere l’impostazione di Benjamin, come quelle che ci mostrano, nel film documentario di Adrian Maben11, il gruppo rock dei Pink Floyd che fra il 4 e il 7 ottobre 1971 registrava dal vivo tre brani (Echoes, One of These Days e A Saucerful of Secrets) nell’Anfiteatro di Pompei vuoto: come se ad ascoltarli, lì e in quel momento, un pubblico ci fosse già – quello, non solo metonimico, di pietre mute divenute blocchi squadrati e poi riassemblati come spalti e scaloni di una platea – o come se un pubblico ci fosse ancora, o ci sarebbe potuto essere, o tornerà a esserci. Musica per altri tempi e per ogni materia.
Molti anni dopo, questa mostra torna a riscoprire Pompei al museo MADRE, come un’ipotetica ulteriore campagna di scavo intellettuale che, assecondando le stesse immagini “dialettiche”, si colloca in quella Pompei reincarnata, in cui questo museo contemporaneo opera, che è la città di Napoli descritta da Curzio Malaparte nelle parole poste in incipit al testo che state leggendo. Che, arrivato ora invece alla sua conclusione, lascia la parola a Massimo Osanna per procedere in un viaggio a ritroso nel tempo, in una triangolazione fra contemporaneo, moderno e antico in cui l’unità e la realtà si danno – come sempre nell’archeologia, ma anche nella (fanta)scienza e nella ricerca artistica, non solo contemporanea – sempre e solo per frammenti, e procedendo per ipotesi.
28 agosto 2017, Hotel Costantinopoli 104, Napoli (all’alba). Versione rieditata e aggiornata il 1 febbraio 2022, in occasione della pubblicazione su www.digging-up.net.
NOTE
1. Cfr. Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 1966 (ed. 1991).
2. Cfr. Sigmund Freud, Il delirio e i sogni della Gradiva di Wilhelm Jensen, in Opere, Vol. 5, Boringhieri, Torino 1975.
3. Walter Benjamin, Tesi di Filoso!a della storia (tesi XVII), in Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962 (ed. 1995), p. 85.
4. Per il concetto di “piega”, i suoi riferimenti al filosofo teorizzatore del concetto di “monade” a essa collegato, Gottfried Wilhelm von Leibniz, e a come tali metafore possano tradurre alcuni parametri neo-barocchi nell’esperienza moderna e contemporanea, cfr. Gilles Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2004.
5. Cfr., di Salvatore Settis, Futuro del classico, Einaudi-Vele, Torino 2004 e le due mostre Serial Classic. Multiplying Art in Greece and Rome (Fondazione Prada, Milano, 9 maggio - 24 agosto 2015) e Portable Classic. Ancient Greece to Modern Europe (Fondazione Prada, Venezia, 9 maggio - 13 settembre 2015) e il rispettivo catalogo: Serial/Portable Classic, a cura di Salvatore Settis, Anna Anguissola, Davide Gasparotto, Progetto Prada Arte, Milano 2015.
6. Cfr. Giorgio Agamben, Aby Warburg e la scienza senza nome, in La potenza del pensiero, Neri Pozza, Vicenza 2005. Ringrazio Rosanna Cappelli per avermi suggerito, durante la redazione di questo testo, di rileggere Walter Benjamin, e Paolo Vinci per avermi permesso di approfondire gli stati della memoria benjaminiana, su cui si fonda la proposta di questa disciplina che non c’è. E ringrazio infine Carolyn Christov- Bakargiev e i suoi agenti, la cui riflessione, condotta nel contesto di dOCUMENTA(13), sulla materialità naturale degli oggetti artistici, ovvero sulla loro origine e destinazione di entanglement con la sfera organica e inorganica naturale, e sulla dialettica fra collapse e recovery nel corso della loro esistenza, sono stati una precaria quanto autorevole ispirazione.
7. Fra i prestatori istituzionali figurano: Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo di Capodimonte; Polo Museale della Campania; Biblioteca Nazionale e Institut Français di Napoli; Casa di Goethe e Biblioteca Istituto Archeologico Germanico di Roma; Fondation Le Corbusier e École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi.
8. Cfr. il catalogo, edito da Electa, Milano, della mostra Pompei e l’Europa. 1748-1943, MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Anfiteatro di Pompei (27 maggio- 2 novembre 2015). Le citazioni contenute nel paragrafo sono tratte dal catalogo e dai materiali connessi alla mostra. Ringrazio inoltre l’architetto Francesco Venezia, autore del relativo allestimento, per avermi indotto ad approfondire, nell’ambito di una conferenza connessa alla mostra stessa, la relazione fra Le Corbusier e l’architettura pompeiana, stimolo per indagare il rapporto fra natura e cultura quale costitutivo dell’esperienza dell’architettura e dell’arte pompeiane.
9. André Malraux, Le Musée Imaginaire, Albert Skira, Ginevra 1947.
10. Da quella del 1908 diretta da Arturo Ambrosio e Luigi Maggi, che fu il primo !lo epico-storico della cinematografia italiana, all’ultima dell’epoca del cinema muto, del 1926, di Carmine Gallone e Amleto Palermi, alle successive, fra cui la prima in Technicolor, del 1959, diretta da Mario Bonnard e Sergio Leone.
11. Adrian Maben, Pink Floyd: Live at Pompeii: Director’s Cut, DVD, Universal Music & Video Distribution, 2003.